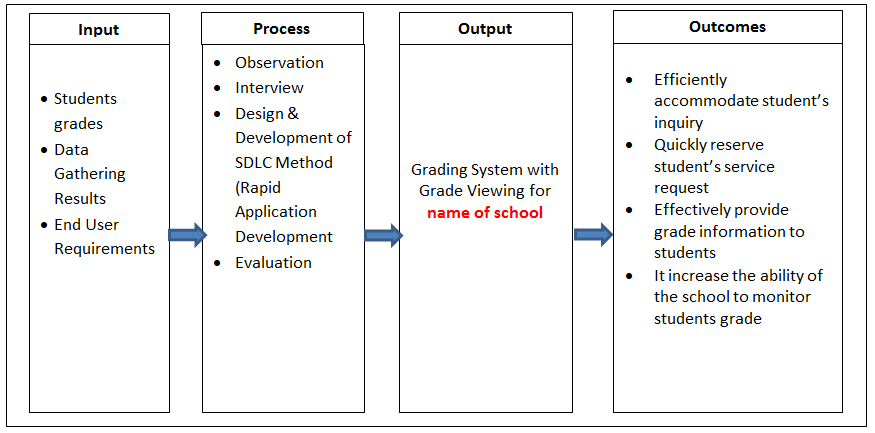Post di Gricelys Rosario
Per leggere l’intervista in inglese clicca qui: Talking with Reena Tiwari: the symbolism of architecture should be social
Reena Tiwari, designer urbana, teorica di strategie di sviluppo delle città e docente presso l’University of Technology di Perth, è stata una dei protagonisti della conferenza tenutasi a Torino il 16 aprile nell’ambito di Biennale Democrazia, organizzata dalla Fondazione OAT. Oltre alla docente di origine indiana, hanno preso parte alla discussione, guidata dall’Arch. Riccardo Balbo, Mario Cucinella e Riccardo Vannucci, che hanno presentato profili ed esperienze diverse. In particolare, Reena Tiwari ha portato la sua esperienza diretta, derivata dai progetti condotti nel suo paese natale, l’India, realizzati con gli studenti dell’Università di Perth e con l’architetto VB Doshi, anch’egli indiano.

© Jana Sebestova, photo courtesy of Fondazione OAT
In quest’intervista Reena Tiwari illustra il suo punto di vista sull’impatto che le migrazioni hanno sull’architettura contemporanea e sul rapporto tra architettura e democrazia.
I suoi studi sono focalizzati sulla condizione degli slum indiani, quei bassifondi in cui vive circa il 60% della popolazione e dai quali deriva il 94% dell’economia del paese: nonostante la loro forte incisione quantitativa, queste aree non sono contemplate nei piani di regolamentazione. La sua esperienza progettuale in India è stata fortemente incentrata sul coinvolgimento sociale: il primo step è consistito nello stabilire relazioni con la comunità, calandosi idealmente e praticamente al suo interno, studiando gli usi ed esigenze. La partecipazione sociale è stato un elemento fondamentale anche per la realizzazione materiale dei progetti: gli abitanti hanno costruito i loro edifici, innescando un meccanismo di identificazione ed un senso di appartenenza alle nuove costruzioni. I risvolti non sono stati esclusivamente immediati e pratici, ma hanno ricadute a lungo termine, innescando un empowerment sociale a più livelli, oltre che la possibilità per gli abitanti di acquisire competenze specifiche. L’architettura così generata è un prodotto derivato dall’effettiva cooperazione tra architetto e comunità, attuando l’approccio che Reena Tiwari ha denominato PEP: Profile, Educate, Partecipate.
Tiwari riconosce la democrazia quando l’architettura è interattiva e flessibile, quando cioè è in grado di consentire a ciascun fruitore l’attribuzione di un significato proprio e la libera interazione con gli spazi che la costituiscono.
Gricelys Rosario: In termini di opportunità lavorativa, l’attuale situazione giovanile non sembra molto promettente, soprattutto per i giovani architetti che intendono lavorare in Italia. La crisi economica e politica è al centro dei dibattiti e questa situazione è stata tradotta in una generale mancanza di speranza.
Reena Tiwari: Penso che il fatto stesso che siano architetti possa dar loro speranza. Parliamo di una professione che concerne la realizzazione di spazi, abitazioni per le persone, progettazione di diversi tipi di luoghi o edifici. Questo dovrebbe dare molto non sono in termini di soddisfazione per la realizzazione di un oggetto, ma considerando cosa una singola persona può fare per le altre, se lo fa nel modo giusto, e come si possa cominciare a influenzare la produzione sociale di spazi e la promozione di relazioni al loro interno. Ovviamente, avendo un’opportunità del genere, un impegno non ottimale sarebbe uno spreco. Ma se lo si fa nel migliore dei modi, possiamo contribuire notevolmente alla costruzione della società. Alcuni dei problemi, per quanto concerne la marginalizzazione delle classi più basse nelle nostre città, possono essere risolti con delle piccole azioni positive, che nella maggior parte dei casi possono essere portate a termine solo dagli architetti. Possiamo dare un contributo concreto solo se siamo in grado di capire la grande responsabilità che abbiamo sulle nostre spalle e, quindi, prendere decisioni giuste ed oneste.
GR: Parlando di responsabilità sociale, lei ha condotto ricerche approfondite sugli slum indiani. Ma c’è una condizione comune in questi bassifondi, presente anche in quelli dell’America Latina, ovvero una significativa migrazione verso i paesi più sviluppati (nel caso del Sud America). Chi decide di migrare si trova poi ad essere nelle stesse condizioni di partenza: lavora nell’ambito dell’economia sommersa, fuori dal controllo statale, ed i soldi guadagnati non possono essere usati o investiti nel luogo in cui si lavora. Quindi questi sono mandati alle famiglie rimaste nel luogo d’origine, sia per migliorare la loro situazione economica che per costruire la “casa dei sogni”. Ancora una volta l’architettura è il modo per esprime un avanzamento dello status sociale, anche se questa non sarà un’architettura esteticamente coerente e non avrà nessun valore di mercato poiché costruita in aree degradate. Ma questo è un uso socialmente e politicamente incentivato, dal momento che i guadagni dei migranti occupano il secondo posto tra le entrate finanziarie, superando il sussidio internazionale, e rappresentando addirittura il 20% del loro PIL. Come l’architettura può essere usata per essere un efficace mediatore sociale tra i migranti e gli abitanti degli slum? Può essere usata per creare un’identità all’interno dei bassifondi al fine di cambiare in qualche modo la sua relazione con il mercato?
RT: Ha sollevato un paio di questioni interessanti. Innanzitutto: la migrazione, sia all’interno del paese (dalle aree rurali a quelle urbane) che transnazionale. Bisogna in primo luogo considerare la causa all’origine, quale sia il loro ruolo come sostenitori dell’economia rurale all’interno della nazione o di quella locale nelle città. Questo è il primo problema da mettere in conto.
Lei ha sottolineato come le speranze siano riflesse nelle loro architetture, come l’architettura sia un indice della presumibile crescita dello status sociale, ma perché è informale, perché non è riconosciuta? Non c’è un mercato, non c’è un valore economico. Questa è la situazione a cui dobbiamo guardare, a come la consapevolezza sociale delle loro architetture possa realizzare un impatto diverso.
In India capita piuttosto spesso nel periodo elettorale che i partiti politici vadano negli slum delle loro aree di pertinenza politica e trasferiscano gli abitanti in altri luoghi,così da avere una grande visibilità. Ma questo succede esclusivamente per una ragione politica. Il risultato è buono, perché queste famiglie sperano di avere un luogo migliore in cui vivere, hanno maggiore stabilità ed incominciano ad investire nelle infrastrutture e così via. Quindi è un metodo che dà buoni risultati, ma parte da un presupposto sbagliato.
C’è un assoluto bisogno di attivismo sociale: dobbiamo partecipare all’educazione pubblica, di coloro che non vedono cosa stia succedendo. La gente continua a considerare gli abitanti dei bassifondi come “gli altri”. Dobbiamo sottolineare il problema degli slum, impedire alla politica che li usi per ragioni di consenso.
Dobbiamo portare queste tematiche di fronte al pubblico e rendere consapevole la popolazione di quale sia il suo dovere nei confronti di questa situazione, nel realizzare una città connessa (in termini di connessione tra ricchi e poveri), nel fare qualcosa di positivo per gli insediamenti più poveri, in modo che possa diventare una città migliore per tutti, da cui trarranno beneficio anche i ricchi, che sia una situazione favorevole per entrambe le parti. Questo problema è responsabilità dell’architettura e dell’attivismo sociale: bisogna cominciare ad educare il pubblico per rendere effettivi questi temi.
GR: Lei era presente alla conferenza di Koolhaas di ieri. Anche lui ha menzionato il fatto che i lavoratori immigrati di Dubai mandino i loro guadagni nei paesi in cui vivevano per costruirsi una casa e, retoricamente, ha chiesto: “Perché questa non è chiamata democrazia?”. Fondamentalmente la questione è che si ha il diritto di possedere una casa solo in un luogo diverso da quello in cui lavori e vivi. Questo come può essere definito democratico?
RT: Penso di condividere parzialmente questo pensiero. Può essere chiamata democrazia, ma, come ho detto durante la mia conferenza di oggi, si tratta di una democrazia socialmente ed economicamente condizionata, a causa del vincolo economico. Queste persone sono migrate dall’India o da altri luoghi perché non potevano avere un buon lavoro, perchè non potevano migliorare la qualità di vita delle loro famiglie in India. Sono stati costretti ad andare a Dubai per cercare lavoro, ma qui soffrono perché sono sfruttati. Ma è la questione economica a tenerli qui. Con quei soldi sono in grado di dare una certa indipendenza, un certo tipo di stile di vita e di benefici alle loro famiglie. In un certo senso, il figlio di lavoratori in India può avere una buona educazione, cosicché sia sistemato. Quindi c’è un certo tipo di libertà nel modo in cui queste persone spendono i soldi che hanno guadagnato. Ma prima vivono lo sfuttamento e questo in sé non è democratico.

© Jana Sebestova, photo courtesy of Fondazione OAT
GR: Ma loro acquisiscono il potere di decisione?
RT: Si, questo è perché la definisco una democrazia economicamente condizionata.
GR: Consideriamo che, in Europa, l’equivalente degli slum indiani sia la questione dell’abitazione popolare, sovvenzionata dal governo. Ricerche effettuate in Francia e Italia hanno evidenziato che c’è una “condizione di transizione”: le persone che vivono in questi luoghi non sono interessate a renderli più vivibili, più confortevoli, poiché pensano di non rimanervi a lungo. Li abitano solo per una questione economica, fino a quando non raggiungeranno un livello migliore. Non è nel loro interesse migliorare questa situazione. Crede che sia una situazione simile a quella indiana? Se sì, pensa che sia possibile rendere la società consapevole che una nuova dignità data a questi spazi possa essere utile sia per il tempo della loro permanenza che per coloro che vi rimarranno più a lungo, come una sorta di accordo democratico?
RT: Sì,ho capito cosa intende dire, ovvero che le persone che vivono in abitazioni popolari sono in situazioni transitorie, consapevoli che un miglioramento delle condizioni economiche li porterà probabilmente in altri posti e quindi non si sentono responsabili perché mancano di un senso di appartenenza al luogo. Questo è il motivo per cui il mantenimento di quelle specifiche aree è scarso ed inoltre da questa situazione così negativa c’è uno stigma che ne deriva.
Penso che si possano fare un paio di cose. Per esempio, le abitazioni popolari sono sempre circoscritte in certe aree, comportando così la stigmatizzazione dell’intero ambito. Credo che dovrebbero invece essere diffuse, disseminate tra le altre, in modo che questo possa permettere di dire “Si, vivo in una bella zona!”. E tutto ciò potrebbe avere un riscontro positivo. Il confinare in aree delimitate le abitazioni popolari non è la strada giusta. Diffondendole sul territorio, gruppi socialmente ed economicamente diversi possono convivere. E’ una situazione ideale, che non avviene mai. Perché? Innanzitutto, le persone dei più alti ceti sociali non lo accettano perché pensano che determini una perdita di valore delle loro proprietà. Ma se si considera tutto sotto il punto di vista dell’aiuto reciproco, allora le case popolari sarebbero ritenute non solo accettabili, ma anche dignitose.
Così avremmo fatto qualcosa di positivo e probabilmente l’impegno del governo nel fornire i sussidi sarebbe alleggerito. Si potrebbe chiedere ai costruttori di sovvenzionare almeno il 15% dell’edificio. Questo potrebbe essere un modo per procedere.
GR: Sarebbe perfetto riuscire a coinvolgere la gente in iniziative sociali, ma nel contesto italiano è molto difficile coltivare l’interesse in attività pubbliche. Manca il senso civico; la responsabilità e l’azione è sempre lasciata allo Stato. L’idea che si possano pretendere i diritti solo quando si sono compiuti i doveri, non tocca molti. Cosa si potrebbe fare per coinvolgere le persone nella definizione della città in cui vivranno?
RT: Credo che questo succeda perché la gente ha vissuto in tali condizioni troppo a lungo. Sono convinti dell’idea che la responsabilità sia dello Stato. E’ un approccio che deriva dall’alto e sono stati abituati così. Ed inoltre non considerano come un loro diritto discutere su cosa accade all’ambiente in cui vivono e partecipare ai processi decisionali. Penso che non ne sappiamo davvero niente, perché sono stati abituati a vivere in quel modo.
Noi, come architetti, possiamo portare qualche cambiamento, perché, come ho detto durante la conferenza, gli architetti rivestono il ruolo di educatori ed è molto importante far emergere la questione. E’ qui che possiamo contribuire ed il risultato è un prodotto realizzato da architetti e società, qualcosa di cui tutti possiamo essere orgogliosi. Quindi penso che, come educatori, saremo in grado di cominciare questo coinvolgimento della gente.

© Jana Sebestova, photo courtesy of Fondazione OAT
GR: Nella sua conferenza ha affermato come gli abitanti degli slum siano definiti “gli altri”. In Europa la cultura araba è spesso trattata in un modo simile: le critiche sono giustificate in quanto rivolte alle “altre popolazioni”.
RT: Penso che si possa parlare solo di alcune cose: siano gli slum, l’Islam o i regimi autoritari in Cina, solo se li vivessimo in prima persona potremmo giudicare la situazione dall’interno e non come degli outsider. Se non si comprende appieno una situazione, non si ha il diritto di esprimere un giudizio.
Stiamo vivendo in una “cultura della paura”, che è stata intensificata con l’11 settembre. Le città e i nostri spazi pubblici sono cambiati con la sorveglianza delle telecamere, le apparecchiature a raggi X. C’è troppa paura nelle nostre vite, dovremmo forse fare un passo indietro e cominciare a guardare le cose in prospettiva. Nel frattempo, penso che dovremmo incoraggiare lo stile di vita di tutti: la gente ha il diritto di vestirsi come vuole, di portare avanti le sue tradizioni e la sua cultura se lo desidera. Vivendo in una società multiculturale, è importante che non siano creati dei ghetti, ma che vi sia uno scambio continuo con il resto della società.
E’ bene avere delle tradizioni ed attenersi a queste, ma è anche molto importante aprirsi e cominciare ad interagire positivamente con l’intera comunità: così saranno rotte le barriere, colmate le lacune e placate le paure.
GR: Nelle sue ricerche parla di densità e propone un uso intensivo dei suoli fino a che questo non comprometta la qualità degli spazi da vivere. Ma forse le città, come le intendiamo noi (per esempio: centro città = alta densità), cambieranno. Consideriamo le città del Golfo.
RT: Bene. Attualmente uno studente del mio PhD sta lavorando sul tema: “qual è la densità ottimale?”. Penso che sia quella che rende l’area sostenibile. Se si vuole un sistema di trasporto pubblico efficiente, allora è necessario avere una densità ottimale per rendere il sistema stesso flessibile. L’idea di insediamenti nomadi, in cui le persone si spostano da un’area all’altra invece che riunirsi, è molto interessante. E’ qui che possiamo cominciare ad utilizzare la potenza della tecnologia: stiamo parlando di case come spazi di lavoro, da cui è possibile fare videoconferenze, shopping e molto altro. E’ un nuovo scenario dove si può vivere, lavorare e, in base alle necessità, spostarsi in altri luoghi. Ha i suoi alti e bassi, perché ci stiamo spostando da uno spazio fisico ad uno virtuale, e l’umanità è in definitiva un animale sociale. Ma abbiamo bisogno di avere uno spazio sociale che abbia una realtà fisica. Entrambe queste idee sono interessanti: possono cooperare, una combinazione di città fisica e tecnologica con una densità ottimale.
GR: Vorrei porle la stessa domanda che ho fatto ieri all’arch. Koolhaas. Questa settimana Gustavo Zagrebelsky, presidente di Biennale Democrazia, ha pubblicato un articolo come anticipazione della sua conferenza di ieri, in cui lui afferma sostanzialmente che la società è strutturata sulla base di tre funzioni principali: politica, economia e simbolismo. Ed il simbolismo è quella che legittima le altre due. Ovviamente, l’architettura concerne la realizzazione o l’interpretazione di simboli. Nella sua visione, gli architetti di oggi sono liberi di costruire un’architettura realmente basata su simboli democratici?
RT: Questa è una questione difficile! Non conosco tutta la storia, nè il contesto. E’ un argomento complicato. Ho notato alcune forme di protesta ieri su progetti per Torino sviluppati in altezza .
GR: La domanda non è correlata alla costruzione del grattacielo a Torino. Ma al ruolo del simbolismo in architettura.
RT: Quindi la mia risposta potrebbe essere completamente diversa. Ha menzionato il simbolismo e come questo legittimi la questione politica ed economica in un certo senso. Ed io sono d’accordo con questo. Un fatto importante che viene tralasciato è l’aspetto sociale. Ha parlato di economia e politica, ma che fine fanno i valori sociali? Come può un’architettura simboleggiare realmente valori sociali? Questa dovrebbe essere la domanda.
Non credo che si possa cambiare il modo in cui ciascuno pensa, ma credo che finchè noi architetti operiamo in modo responsabile e se le nostre strutture governative sono preparate a sostenere un processo democratico, allora l’inclusione del simbolismo è l’unica cosa che abbiamo nelle nostre mani, sotto il nostro controllo. Non abbiamo molto altro sotto controllo.
GR: Grazie per l’intervista.
RT: Grazie a lei. Devo ammettere che ho apprezzato molto le sue domande.
Testo tradotto da Alessandra Pellicanò